|
Socìetas Raffaello Sanzio
Sul concetto di volto nel figlio di Dio
Ideazione e regia Romeo Castellucci, con Dario Boldrini, Silvia Costa, Gianni Palazzi, Vito Matera, Sergio Scarlatella, musica originale Scott Gibbons
Visto al Teatro Era, Pontedera, il 20 novembre 2010
|
 |
"E ancora adesso, che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino” (Lucia Dalla, “4 marzo 1943”).
Una tragedia quotidiana, normale, comune, che tocca, ha toccato e toccherà ognuno di noi. Ed alla quale nessuno arriva pronto. Che prima lo sai, ma poi, quando arrivi lì, a due passi dal dramma, ti crolla, comunque il mondo addosso. Nella sublimazione del processo della perdita della vita, prima della dignità e del rispetto per se stessi, di Romeo Castellucci, il volto gigantesco di Cristo ci guarda impotente. Ma non
è inebetito, non è altrove, non è distante né
lontano. Castellucci versus questo Gesù che partecipa al nostro dolore, alla nostra
sofferenza, ma non può dare sollevazione né salvifica benedizione.
Guarda, c’è e non lascia soli. Per chi crede, non ti abbandona mai. In un appartamento lindo, pulito e moderno, snocciolato per largo, quasi ad allargare la potenza economica delle cose che si possono avere per migliorare il proprio stato, come una pancia in polluzione, gli escrementi e le feci, che l’anziano padre non riesce più a trattenere nel pannolone, diventano l’elemento che ci riconduce alla vita (balena alla mente “Pulendo il culo di mia madre” di Iain Heggie, visto ad Intercity
Edimburgo ’05). Dove se ne stava la linfa senza quest’uomo,
finito, sfinito, al termine, al capolinea, rallentato e sedato, se non s’avverava l’avvento epifanico di questa colata marrone che almeno dona un tocco di colore al tutto rarefatto e falso e finto? Il padre, bianca la barba, bianchi i capelli, bianco il divano, bianco l’accappatoio, è indifeso nelle braccia di un figlio, per quanto manageriale e discreto e deciso, che passa da un “Che cosa hai fatto papà?”, quasi incredulo, ma comunque disponibile, amorevole, accogliente, estremamente
cortese e gentile che si accolla caritatevolmente, con pietas, su di sé
la disgrazia traumatica senza farla pesare all’anziano genitore, ad un incapace e straziante “Che cos’hai?”, urlato a mezza voce, pianto inconsolabile ed insaziabile come un bacio, passaggio ultimo, esalazione.
La vita del padre sta scorrendo davanti ai suoi occhi e non c’è niente che lui possa fare, come niente può fare quell’immenso volto pieno di generosa religiosità che ci guarda e che sembra essere vivo, che può tutto e non può niente contro il quale si rivolge la
rabbia di Castellucci nel suo atto di vergarlo, punirlo, tranciarlo,
insozzandolo, urlandogli il suo luminoso messaggio “Tu non sei il mio
pastore”. Semmai esiste un colpevole questo è il Padre, non Cristo
fattosi uomo. Che forse è meglio non averne, che credere di averne e poi
scoprire che non ce n’è traccia nel momento del bisogno. Ed è anche una rivoluzione iconografica. Un Dio debole e infartuato, decrepito e marcio, che un Cristo moderno, tutt’altro che martire
però, accompagna, senza saperlo e senza volerlo, verso l’ultimo
respiro. Tutto si sporca, tutto si rovina, tutto è da buttare. E’
il paradosso della vita che vivendola si sgualcisce, ed è proprio lì che alberga la sua intima bellezza, nella sua potenzialità di effimero, di friabile, di scioglievole, di inceneribile, di attimi che non
tornano. La vita se ne fugge, inesorabilmente, in un senso unidirezionale, proprio dalla porta di servizio, quella usata nel resto degli anni per gli atti più “sporchi”, per gli istinti più bassi, la parte
vilipesa e nascosta, offesa ed oltraggiata. Da lì esce in un’emorragia che non si ferma andando ad implodersi ricoprendo il candore
falso nuvola di un paradiso in terra senza lanugine. Ed infatti non è diarrea
quella che sgorga nel pianto abbracciato di due uomini vinti dalla vita, per uno non c’è più e per l’altro deve continuare ad esserci anche dopo, una fontana con il rubinetto aperto senza alcun idraulico pronto a porvi rimedio. E’ una lenta agonia immobile, la sofferenza che
la vita ci regala, senza alcun Maestro ad insegnarci la rotta giusta, dimenandoci tra gli errori inevitabili. Come dice il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, “Non
moriamo perché ci siamo ammalati, ma ci ammaliamo perché dobbiamo
morire”.
Voto
8
|


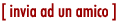 |
|





