Centottoantacinque progetti arrivati in sede, scremati in una trentina, dalla quale ne sono usciti, dopo
attenta valutazione della fornita e qualificata giuria, quattro estratti di un
quarto d’ora. E’ il Premio
Lia Lapini che trova il suo apice all’interno del festival “Voci di Fonte” a Siena, sparpagliato tra
il Teatro dei Rinnovati, la sala omonima, dedicata alla giornalista teatrale e
docente scomparsa una decina d’anni or sono, e, appunto, la splendida e
scenografica Fonte di Pescaia. Il limite, semmai, è la scelta su carta, in base
alla descrizione del progetto, alle note di regia. Tutto e il contrario di tutto.
La realizzazione è un’altra storia. Si fa teatro, non letteratura. Comunque. Ha
vinto a mani basse, per manifesta superiorità, il primo lavoro presentato, “Innerscapes” a cura degli Effetto Larsen,
unica opera delle quattro superstiti ad avere, a dare l’impressione di un
concreto sviluppo, di un divenire, di uno snocciolamento
ed approfondimento, di un working progress tutto da
fare, da vedere, da sentire. La materia c’è. La freddezza dei sentimenti. Se sul frontespizio della scena, sul boccascena (che alla Lapini
non c’è), stanno delle lettere alla maniera del cruciverba, del sudoku, ingranaggi alla Bartezzaghi, giochi di parole da
prestigiatori dislessici, dove cambiando una consonante si aprono mondi nuovi,
semantiche perverse, etimologie lunari, dietro, sul fondale, come pesci in un
acquario immobile che improvvisamente si anima per poi, altrettanto
improvvisamente, ritornare alla posizione originaria, i due amanti scivolano e
gattonano nel loro percorso di conoscenza-amore-odio-fine,
la più consueta decostruzione di un amore. Impassibili i due si
guardano, come in un fotogramma in bianco e nero, uno scatto, una posa che pare
infinita, un fotoromanzo, mentre intorno altre figure
addobbano, vestono, addobbano, abbelliscono, trasformano e trasfigurano il
panorama. L’azione è brevissima, come un allungo da centometristi. La
preparazione, i preliminari si estendono, l’attesa si gonfia, l’amplesso è un
attimo circospetto, proprio per questo potente come una scarica d’idrante senza
scialacquare parole vane. Uno scenario montato e smontato, un
teatro Ikea, toccante, vero, serio e faceto, divertente nelle sue digressioni
musicali. I tre successivi ci hanno deluso. In un ambiente ostile da
laboratorio, dentro una ipotetica teca, un “Topo”
(titolo certo scontato e per niente accattivante), di Dario
Giovannini con tanto di didascalica maschera, si aggira tra vari oggetti,
tra gong, cioè “si può fare”, e allarmi, cioè “è vietato”. Siamo topi nel
grande rettilario della vita aspettando ognuno il proprio pitone. Input e
ordini, accettazione e negazioni sono alla base del nostro trascorso; i
cosiddetti pre-giudizi. Ma le regole cambiano in corsa lasciando basito il topo
e noi, di conseguenza, nell’assoluta ripetitività
delle azioni scandite da ancestrali rigurgiti. I topi in gabbia, che non possono neanche fuggire dall’afa della Lapini, sono gli spettatori. Un
esperimento li salverà: la vita è quella malattia che solo la morte può guarire.
Meglio essere topi da biblioteca oppure Ratatouille. Un burattinaio avvinazzato
è invece il capocomico che giostra le piccole maschere all’interno della propria carrozza in “Pinocchio. Studio per una fiaba alcolica per adulti”, primo dei due titoli wertmulleriani, con Massimiliano Venturi, diviso artisticamente tra il Belpaese e la Polonia. Ciò detto una sgangherata compagnia di figurine cialtronesche che si articolano tra il toscanaccio e il veneto sboccato da commedia dell’arte, intercalandosi, interfacciandosi, confrontandosi in un duello dialettico fuori e dentro il teatro. Intanto il burattinaio beveva, da cirrosi epatica, una sostanza rossastra, simile a quella molto alcolica versata ed offerta in cicchetti e shot al pubblico prima di prendere posto. Tra trucioli e una vaga aria alla Fo, un’atmosfera circense da Zampanò, appaiono vari personaggi della fiaba come della Commedia come tappi di sughero intagliati per altrettante bottiglie, tutte da consumare fino all’ultima goccia, in macchinerie da alchimista, fantasie trasognanti di sogni allucinati. Si chiude con la scena naturale, da sfruttare anche in altre occasioni!, della piscina delle fonti (la parte migliore della piece) dove al suo interno si aggira un killer della mafia (Salvatore Zinna). Non è assolutamente un pentito, la sua è una confessione a cuore aperto che ha come intimo ed ultimo messaggio la spiegazione a noi piccoli e poveri borghesi l’atroce, squallida e reale verità che la Mafia non è l’antistato, ma una parte dello stesso, ed i suoi sgherri devono essere messi sullo stesso piano dei soldati in missione in Afghanistan. Sul fondo abiti rosso sangue che sono le vittime delle stragi, degli omicidi su commissione, dei vari e continui regolamenti di conti, che vengono riesumati dal fondale fino a vederli scomparire nuovamente nell’abbraccio dell’acqua che tutto copre, nasconde e opacizza. Il racconto però è debole mentre ci insegna a pulire, ingrassare e curare il ferro del mestiere, da qui il lungo titolo “L’arte della filettatura a banco con maschiatori e filiere”, l’interprete non troppo credibile nell’accendersi. Una denuncia che avrebbe avuto bisogno di più spinta emotiva, di più pathos, più forza e vigore. Era ovvio che primeggiassero i Larsen.
Voto
7 +
|


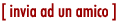 |
|





