Emilio Fede dice che non se ne
può più di Saviano e della sua
lotta con le armi della parola alla Camorra. Noi, invece, ne vogliamo sentire
ancora. Vogliamo continuare ad ascoltare Beppe
Grillo e Sabina
Guzzanti, Daniele Luttazzi e
Giulio Cavalli, Travaglio
e Dario Fo e Bebo Storti, Report
o Santoro, che sia Don o Michele. Un Albero senza ombra
è una società senza memoria, che lascia passare l’acqua senza tenerne le gocce,
senza ricordare il passato, senza ricercare la giustizia, senza capirne i
passaggi, le forme, i percorsi, i destini. Un mondo anestetizzato, senza
società civile, dove tutto può accadere perché tutto è contemplato, assuefatti
al peggio, sdoganato, dopato, tutto è permesso, niente è vietato. La bilancia
perde sempre dalla stessa parte e la Giustizia è cieca o quantomeno bendata. Le regole
ci sono ma non valgono, non sono rispettate. Un’altra Marzabotto, un’altra
Sant’Anna di Stazzema, altre foibe. Quanti massacri
nascosti nella polvere del dimenticatoio, eluse dai media, messe sotto il
tappeto della disinformazione. Cesar Brie ci ha messo
la faccia (assieme al medico legale Alberto Brailovsky, grazie al quale sono
cominciate le ricerche e che adesso rischia il carcere e la vita). Ha lavorato
un anno e mezzo attorno alle notizie che arrivavano dalla giungla. Ha
intervistato i sopravvissuti di questa strage sconosciuta, immersa nel fitto
della boscaglia. Una strage dimenticata di campesinos
avvenuta l’11 settembre 2008. Quanto vale un contadino boliviano? Neanche lo
sforzo di un trafiletto. Cesar ha
pagato la verità. La sua ricerca lo ha portato ad
essere minacciato, colpito, picchiato. E’ dovuto scappare da Sucre
dove viveva con la famiglia da venti anni e tornare in Argentina dalla
quale, il cerchio si chiude, era scappato dalla dittatura quando aveva
diciannove anni. Solo sulla scena, Brie si veste di tutti i personaggi della
vicenda, indossa gli abiti dei soldati, delle madri, dei contadini esasperati
senza futuro. E ne dona la sua versione a metà tra il sogno colorato e la cruda
realtà. Attorno le foglie secche delimitano il passato
bruciato dal presente. Camminandoci sopra, come una frontiera, un limite, un
destino. Dalle foglie usciranno i cappotti che saranno le figure che Brie
resusciterà, le fotografie in bianco e nero incassate nella farina gialla di
mais, la stessa per la quale i campesinos hanno
combattuto e sono morti. Le corde cadono dall’alto come contrappesi a farne
carrucole e cappi. I cadaveri sono cenci bagnati nel fiume gocciolante di un
secchio. Tutti i deceduti amavano la vita, i suoi colori, i profumi, le piccole,
parche gioie quotidiane. E Cesar
racconta con voce cronachistica, prima di lanciarsi in balli frenetici a
scacciare la morte, la paura, la disperazione. “L’albero senza ombra” è il
fusto del caucciù, dal quale si estrae la gomma. I suoi rami sono radi,
lavorarci sotto è un mestieraccio, un massacro di
schiena e sudore. I contadini lottano per avere la terra da coltivare, terra che è cibo, presente e futuro. I latifondisti
assoldano per venti euro al giorno sicari e squadristi provenienti dal Brasile.
Un sacco in alto rotea, ondeggia avanti e indietro come punching ball da boxer.
Ne esce una lingua gialla, uno strato che sarà il fondale e il terreno del
racconto, che si fa fiume e terra. Come nella
precedente piece Odissea ritorna forte e potente il
tema dell’emigrato, non tanto geograficamente, quanto dell’animo, del sentire:
“Sembra che non siamo mai del posto dove siamo”. Un essere
apolidi perché non degni, un essere profughi perché scacciati dalla
propria terra, non riconosciuti dai governi. Ora Cesar è il capo delle squadre
della morte, perché, in fondo, “i morti sono tutti uguali”. I campesinos sono i
nostri partigiani. Cesar Brie in un incontro informale mi dice che la Bolivia di oggi è ben
rappresentata dal romanzo “La
Malora” di Beppe Fenoglio. Racconta
lo stesso agguato, lo stesso attacco, la stessa
giornata di dolore da più punti di vista. E nelle sue parole è come se un altro
attacco, questa volta concentrico e verbale, dialettico e sillabico si
concentrasse attorno al tema, al tempo fermato dalle pallottole. Come in una
trance da sciamano a rievocare gli spiriti che sono rimasti nell’aria a
parlare, a lamentarsi, a domandare, per ristabilire il confine tra il sogno e
la realtà, tra l’incubo e la giustizia. Gli ultimi attimi sono vissuti con
distacco e distanza dai caduti: raccontano la propria morte con lucidità, senza
il dolore dell’attimo, ripercorrendo i motivi del loro essere lì. E fa ribrezzo
sentire che i preti che uccidono, dando il colpo di
grazia. Che i dottori (forse si sono scordati il giuramento di
Ippocrate, come avrebbero voluto imporre a quelli italiani denunciando gli
immigrati irregolari bisognosi di cure mediche) che lasciano morire dissanguati
gli indios colpiti dalla polizia, i dottori collaborazionisti con i poteri
deviati, medici che falsificano autopsie, dottori assassini che stilano falsi
referti per i deceduti, che non prestano i medicamenti
necessarie, che non dichiarano invalidi gli infermi in sedia a rotelle. Viene
in mente il G8, il caso Cucchi. Non siamo poi così lontano dalla Bolivia.
Voto
8
|


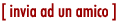 |
|





