|
Mulholland Drive
Regia di David Lynch
Cast: Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Elena Harring, Ann Miller, Robert Forster. Produzione: Les Films Alain Sarde, Asymmetrical, Usa/Francia 2001, C, 146'
Abortito dalla TV, l'ultimo film di Lynch, risorto dalle sue ceneri, costruisce trame tortuose aprendo squarci di oscurità nelle menti degli spettatori
|
 |
Nel 1999, dopo l’accoglienza controversa di Twin Peaks (la prima serie era stata
un successo, la seconda meno) e di un altro paio di serial, Lynch propose alla ABC l’episodio pilota
di un nuovo telefilm. Gli fu rifiutato; certi produttori francesi ne acquisirono
i diritti e convinsero Lynch a farne un
film: queste sono le origini di Mulholland
Drive, e valgono ben più del racconto della trama. Non era preso sul
serio, Lynch, come non erano presi sul serio i Coen (almeno fino a
Fargo). Sarà un caso che L’uomo che
non c’era e Mulholland
Drive abbiano vinto la Palma d’oro alla regia nello stesso anno?
David Lynch, in occasione di Strade
perdute, ha fatto riferimento all’anello di Moebius: un cerchio la cui
superficie si estende a spirale, di volta in volta all’interno e all’esterno dell’anello
pur restando unica e che viene rappresentata, graficamente, col simbolo dell’infinito.
Stesso accostamento può essere fatto per Mulholland
Drive, che prosegue lungo l’itinerario delle opere più oniriche e
tortuose di Lynch, da Eraserhead al
tanto disprezzato Fuoco
cammina con me, a Strade perdute,
appunto, di cui Mulholland
Drive sembra quasi il film “gemello” (stesso direttore della
fotografia, Peter Deming).
Ciò che accomuna queste due opere, dal punto di vista della
percezione del pubblico, è una certa frustrazione nel momento in cui, più o
meno verso la fine del primo tempo, sembra di aver perso qualcosa, un dettaglio
fondamentale perché la capacità di comprensione viene decisamente a mancare. Quello
è invece il momento di lasciarsi condurre dal film come fosse uno strano mezzo
di trasporto, senza porre domande. L’esperienza, con David Lynch, è in primo luogo
sensoriale, avviene per accumuli e stratificazioni, ignora totalmente la logica
(figuriamoci i cliché). In secondo luogo, insegna che non si può usare la mente
per indagare la mente stessa: è come voler guardare i propri occhi senza l'ausilio di uno specchio.
La mente sfugge sempre, restano sempre dei buchi, delle zone d’ombra,
e così avviene nei film di Lynch: prendere o
lasciare.
Un’idea di cinema talmente indipendente dai gusti (di
critica e pubblico) da consentirgli non solo di usare una chiave per accedere,
tramite una scatola blu, alla seconda parte del film, che è in realtà un altro film (un po' come succedeva con
il tuffo nel lavandino in Barton Fink dei fratelli Coen), ma anche di
enfatizzare la presenza minacciosa di personaggi che platealmente preannunciano
ulteriori apparizioni che poi non avverranno, come il Cowboy: qualunque altro regista
mainstream avrebbe almeno colto l’occasione per un cameo accattivante (Sam
Shepard o Kris Kristofferson, o che so io). Lynch adopera invece un illustre
sconosciuto, dalla fisicità del tutto antitetica a quella che ci aspetteremmo e,
proprio per questo, doppiamente inquietante. E chi diavolo è l’”uomo nero” dell’incubo?
Meravigliosa e assolutamente centrale (per chi ancora cerca
un centro) la scena nel teatro, dove si mette in scena, denunciandola, l’illusione.
E’ quasi una dichiarazione di intenti: Sì, il mio cinema funziona così, come
agli inizi: tirare fuori conigli dal cappello. Tutti sanno che è un’illusione,
eppure lo stupore non cessa.
Le splendide musiche sono di Angelo Badalamenti, compositore
insostituibile di Lynch a partire da Velluto blu: una coppia
perfetta, o meglio un corpo unico, come pochissimi altri (Preisner/Kieslowski,
Herrmann/Hitchcock).
Voto
8 1/2
|


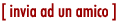 |
|





